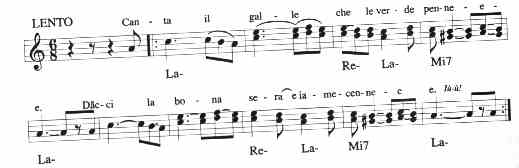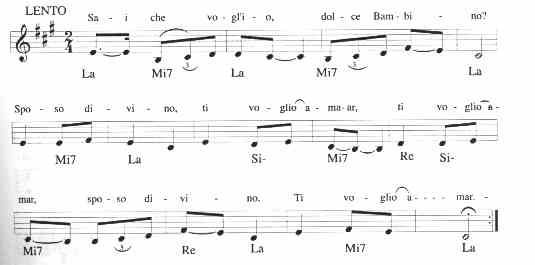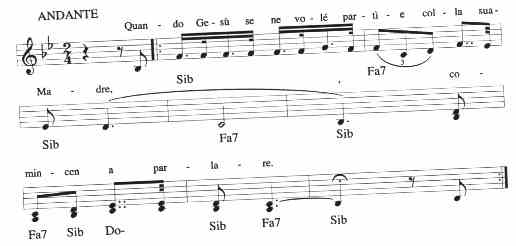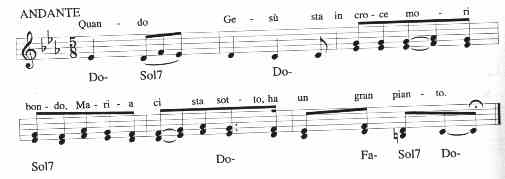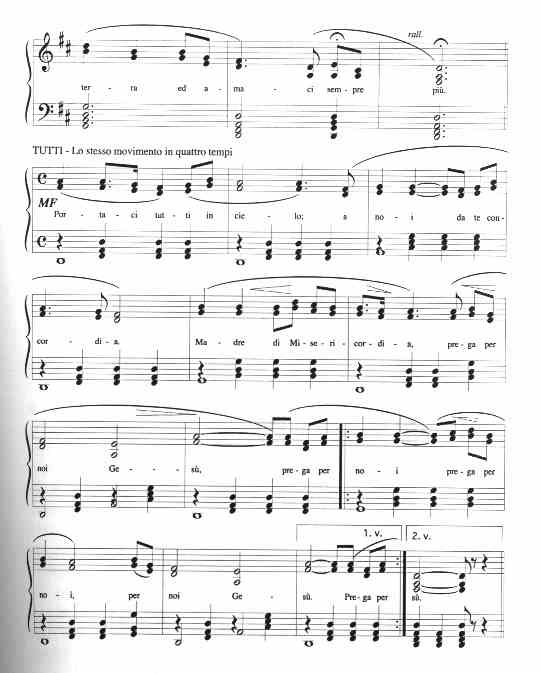|
ALCUNI CANTI
I canti che seguono, fanno parte della tradizione. Spesso si
presentano in più versioni. Di ognuno riporto quella più ricorrente. I
versi a volte sono in dialetto stretto (in tal caso la vocale e
è “muta”); altre volte sono in un dialetto italianizzato (in tal caso la
vocale e va pronunciata
chiaramente). Comunque, quando è scritta in grassetto, la e va pronunciata
chiaramente. Stornelli
Il canto degli stornelli nel passato costituiva il momento più esaltante nelle feste paesane. Tutti li cantavano per esprimere allegria, amore, odio, gelosia, invidia, dispetto, tristezza, ma soprattutto per esprimere la gioia di cantare in piena libertà, senza remore o inibizioni di sorta. Gli stornelli avevano origine diversa: potevano essere importati da regioni più o meno lontane, potevano essere tramandati di generazione in generazione, potevano essere improvvisati sul momento. Quasi sempre si accompagnavano al suono dell’organetto. Ogni stornello si compone di 3 versi. Il primo può essere di 11 o di 5 sillabe. In quest’ultimo caso va tagliata la parte iniziale del canto (equivalente a 2 battute musicali). Gli altri due versi (il 2° ed il 3°) sono di 11 o 12 sillabe (e a volte di 10). Quando in uno stornello i versi sono solo 2 (come capita spesso), il secondo va ripetuto, in modo da avere l’equivalente di 3 versi.
All'addasciùme[1]
c'è ‘na grossa pioggia, quest'è l'amore mia che ci passeggia. (2 volte il 2° verso) Amor’amore, l’amore
non si fa sse non si monta, se
nen se mette ‘ncuórpe la semènta. Amore
mia, ‘na
sera tu sié ditte a mé
“carogna”; ma
n’atre cómm’a mé glie truóve ‘nfré… Amore
mia, nne
me ne cure se ‘mpuórte la robba, basta
che puórte sana la percoca. Amore
mia, sié
ditte ca veniv'a scartecciàje. Glie
marre[2]
suo’ fenit’i nen sié venute. I
guarda che vertù che tè la donna, porta
l'acqua ‘ncape i nen se ‘nfónne. ( 2 v.)
Porta l'acqua ‘ncape i nen se ‘nfónne,
porta le méla ‘mpiétte i nze le magna,
quanne piglia marite ce le quenzégna. I
l'acqua deglie mare è turchinèlla, la
léngua delle donne è parlarèlla. (2 v.) Io
me ne
voglio andà lontano tanto, dove
non mi ritrova nemmeno il vento. (2
v.)
Nemmeno
il vento,
manco la luna che cammina tanto. (2
v.) I
quanne nascé ie, nascé la rosa; nascé
la gelosia della casa. (2 v.) Ie
tiénche ‘ne marite ciche ciche, glie
so’ mannate agli uórte pe 'nzalata, ‘na
ciammaruca spóglia gli è spaventate. La
mamma del mio amore non mi parla, se
créde ca i vuóglie amà la figlia. (2 v.)
Se créde ca i vuóglie amà la figlia,
pe mé che se glie faccia fritt’all'uóglie
i repassate che ‘na spica d'aglie.
La
vita della donna è cómm'all'uóglie: la
sèra è bbona i la mmatina è miéglie. (2 v.) Merìquela,
merìquela de fratta, ie
cchiù te guarde i cchiù te fè morétta. (2 v.)
‘Ncim'aglie
piétte ti' ‘na cèrqua tónna, teccasse
própia a mé raccò la glianna. (2 v.) O
Filomena, quando
cammini pe 'ssa strada piana. la
gonna balla e la terra
trema. O
Marïuccia, remitte
glie pecine ca chievìzzeca, sennó
vè gli acqua-frusce i te gli acciòppeca. O
tira tira, quattro
cavalli tirano le rote e
lo mio amore tira la calamita. Un
giorno me n'andavo fosso fosso, trovai
lo mio amore a lavà le cosse.
(2 v.)
Trovai lo mio amore a
lavà le cosse,
allora io ci disse: "Che stè a fà iésse?"
E lei mi rispose: "Quanta sié féssa!" Amore
mia, nne
vuóglie cantà cchiù ca mó me basta, la
voce p'addemane nne me rèsta.
Peppinèlla “la ricciolina”, la simpaticissima ultracentenaria
della Forcella,[3]
quando è di buonumore, cioè spesso, intona ancora, con voce schietta e
ben cadenzata, gli stornelli che seguono: Sse
me guardate, dicetimélle
che cosa voléte. Voléte
glie mio cuore? Perché ‘mparlate? Amava
‘na morétta montagnola: chélle
ch’avéva in cuore mi le dicéva.
Mó che s’è fatta
furba, ‘sta vagliona,
chélle che tiéne ‘ncore
se lo mantiéne. Andato
pe ‘ssa strada, mèzz’a
ni boschi morta pe la séte, per
bere,
bello mia, róscia ‘ncarnata,
mi dài ‘na béveta d’acqua, se ce
l’avéte?
Chélla mi disse: “Bive alla cannata,
refréscati ‘ssi cuor quanta voléte.” Sentì
‘na voce, chiglie
è lo bello mia, vo’ rifà
pace.
E ce venisse gli
Angel’alla Croce,
ca ie che tè nen ce
refacci pace. Bène
ti voglie, a
pasci l’èrba cómm’agli aconiglie,
a pasce l’èrba cómm’agli aconiglie,
le béne che t’ho date le
rivoglie.
A Campoli Appennino, che dista 3 o 4 km. da Pescosolido, si cantano
questi altri stornelli.[4]
Per la maggior parte sono in lingua italiana e perciò la vocale e
va pronunciata chiaramente. Solo qualcuno è in dialetto (e quindi con la
vocale e “muta”). Affàcciati
in finestra, se ci sei; dàcci
‘na goccia d'acqua, se ce l'hai; se
non ce la vòi dà, padrona sei. Bellina
che ti tengo facciafrónte, non
ti posso parlar, ti tengo a mènte. (2 v.) Eccoci,
bella mia, son ritornato, le
tue bellezze m’hanno richiamato. (2 v.) Fior
di chepèlla, staséra
me la sento
calla calla: me
va da litigà co’ la copèlla. Fior
di limone, con
la farina se fa le pane, co’
le ragazze se fa gli amóre. Fior
di radice, la
figlia della vedova mi piace se
la potessi avé, campo felice. Fiore
di menta, ie
m’ ðglie métte ‘mpiéd'all'acqua santa,[5] che
‘n'occhie guard'a Dije i ‘n'altr'all'amante. Fiore
di menta, la
menta non si coglie se non si pianta, l'amore
non si fa se non si monta. Fiore
di pepe, se
non ce la vói dà, fàccela véde, la
peparola pe pestà le pepe. Ie
me ne
voglio ì vèrzo Liórno[6], dove
ci sono chésse (o
ce l'ave ditte)
che
ce
la dànno la
sera, la mmatina e a mezzogiorno. Io
di stornelli ne sacce tante, ne
pòzze carecà ‘ne bastemènte. Chi
ne sa cchiù de mé, se faccia auante. I
quanne la ceciara se marita, i
chi ce dà glie spache i chi la ciocia. (2 v.)
Chi ce dà glie spache i chi la ciocia,
i chi ce dà la pizza ‘nquelerata (o
‘ncennerata). (2
v.) La
bella mia sorella Filomena, se
l'è portata via la tramontana, se
l'è tirata via l'aria serena. La
vostra madre nte marita apposta, pe
nne leuà la rosa alla fenèstra.
(2 v.) Ma
quanta sona bène ‘st’organétte, ma
quanta c’è cchiù biéglie chi glie sona, le
corde so’ venute da Milano. Sona,
sinatori, sinate alègre, ce
la volemi fà festin'e cante.
(2 v.)
Ce la volemi fà festin'e
cante,
ce la volemi fà
‘n'ora contènta.
(2 v.) Vede che
zinale fatte a lènza
(o a pizzo), quando
cammini si véde la panza se
véde glie boschétte de Fiorènza (o
tra le colonne).
Uno stornello di Sora:
Amore
mia,
sse
màmmeta nte nzóra[7],
me glie taglie,
glie
métte pe pennàcchie aglie cappéglie.
E uno di Balsorano:
Nne
véde l’ora che
viene
San Giorgio,
vedere
allo mio amore
glie stannarde.
(e
per assecondare il frunna-franna
dell’organetto)
Lé-vig-gé,
Lé-vig-gé,
Le-vig-gé, Le-vig-gé.[8]
Canti “alla stesa”
Venivano eseguiti a tutta voce ("alla stesa", appunto) in varie circostanze: quando si lavorava
nei i campi, quando si scartocciava, quando la sposa trasportava il
corredo alla casa dello sposo, quando si festeggiava la visita di amici
ecc.
Quando i campi si lavoravano a mano (con la zappa, la vanga, la
falce ecc.), si cantava sempre, un po’ per alleviare la fatica ed un
po’ per il gusto di cantare. Attaccava una squadra intonando una strofa,
da un campo più lontano rispondeva un’altra squadra con una seconda
strofa, da un campo ancora più lontano rispondeva un’altra squadra con
una terza strofa… e così il canto si rincorreva da un punto all’altro
del territorio. C’è da dire che allora non c’era l’inquinamento
acustico. Officine, motori ecc. non esistevano. Solo il mormorio dei
ruscelli, lo stormire delle foglie, il cinguettio degli uccelli ed altre
voci discrete della natura rompevano il silenzio; ma non impedivano ai
canti di diffondersi liberamente nell’aria.
Un’altra occasione buona per cantare (ma anche per ritrovarsi
tutti insieme a chiacchierare, a scherzare, a ridere e a fare festa) era glie mentóne[9].
Di seguito riporto quattro di questi canti alla stesa. Li ho
raccolto dalla viva voce di chi li eseguiva tanti anni fa.
Questo canto, quando arrivarono a Pescosolido due carbonari di
Veroli che avevano sposato due pescosolidane, riprese improvviso vigore,
poiché i due coninciarono a cantarli di frequente insieme con le loro
mogli. Solo che ci confondevano le idee, poiché sostenevano di cantarli “alla
cepranese” e noi non capivamo se si riferissero al modo di cantare o
all’origine del canto.
Mi pare
che vo’ chiove e
doppo lassa, cómm’alla donna quando si
confessa. (2 volte
il 2° verso)
Cómm’alla donna quando si confessa,
comincia li peccati e doppo lassa. (2
v.)
La mamma del mio
amore si chiama Memma; ma se
mi dà la figlia, la chiamo mamma. (2 v.)
Ma se mi dà la figlia,
la chiamo mamma,
sennò la chiamo scellerata donna. (2 v.)
Appicca glie
callare i fa' la sagna: mó passa lo mio amore
e se la magna.
(2 v.)
Due erano i luoghi ideali per eseguire questo canto: glie Pentóne ‘e Cantajalle e la
Prètacquara (che si trovano a monte della Forcella), i quali, essendo
bene esposti sulla valle di Sora, permettevano alla voce di arrivare
lontano lontano. Le ragazze, passando di lì, erano prese da una voglia
insopprimibile di intonare il canto (così dice Maria “la
macellara”, che me lo ha fatto riascoltare).
La vocale e va sempre pronunciata.
Canta il galle che le
verde penne-e-e,
dàcci la bona sera i iamecenne-e-e.
Iù-ù!
(grido festoso e allusivo).
E
mó che fresco c'è, lo buon cantare
cominceno zitèlle in amore.
E voi che
state a terra a ‘sse vallécchie,
mi sembrate
l’asino senza ‘récchie.
E
voi che
state a terra a chéssa valle,
mi sembrate
l’asino con le palle.
E
tu che stè’ a terra a chéssa valle,
s’ ô fa gli amóre che mé, viétténn’abballe.
All’addasciuma,
llariolé, se véde ‘na cammìscia
biancolina, oilé. O biancolina,
llariolè, è quella del
mio amor che vo’ fà pace, oilé. O
llariolì, o llariolé, chi
ce se vo’ trevà, che ce se trova, oilé. Che
ce se trova, llariolé, le
bianco letto e le lenzola fine, oilé.
Questo canto veniva eseguito allorché la sposa trasportava il
corredo alla casa dello sposo[10],
cioè qualche giorno prima del matrimonio. Le vicine di casa la aiutavano
portando sulla testa glie caniéstre[11]
o la canèstra[12]
pieni di panni, casseruole ed altri oggetti (sotto ai quali, però,
avevano messo un ringrosso per far apparire molto ciò che molto non era,
poiché anche allora contava tanto l’apparenza). Procedendo in fila
indiana, le donne cantavano accompagnate dall’organetto, che andava
avanti a tutte. Questo meraviglioso strumento, che era arrivato dalle
nostre parti tra la fine dell’’800 e l’inizio del ‘900, sostituì
la zampogna e con i suoi trilli festosi ravvivò i rari momenti sereni dei
nostri antenati. Però aveva il fiato corto, poiché il suo mantice era
piccolino[13],
ed incontrava non poche difficoltà nel sostenere le lunghe e lente frasi
del canto alla stesa, sicché si limitava ad interpolarle con fraseggi ad
libitum, in cui si rivelavano la bravura, il gusto e l’estro del
suonatore. Il canto si componeva di tre momenti distinti: l’assolo
dell’organetto, piuttosto veloce e cadenzato; il canto, lento ed
appassionato, eseguito dalla voce solista e sottolineato qua e là da un
veloce fraseggio (ad libitum) dell’organetto; il coro che, inserendosi
nella parte finale della frase musicale, si univa alla voce solista
vocalizzando sulle ultime tre note in segno di approvazione e
compiacimento su quanto era stato espresso dalla voce solista.
La e
(in grassetto) va pronunciata chiaramente.
(Solo) Mannìscete glie pènne[14],
o ‘gnóra spósa-a-a-a,
(coro) a-a-a, (solo) ca c'è ‘rrevèta l'ora de
partìe-e-e-e.
(coro) e-e-e. Alla
casa deglie padre sospir' e piante-e-e-e,
(c.) e-e-e, alla
casa degli amante sorris'e cante-e-e-e.
(c.)
e-e-e. Ti
vengo a riverire, signora sposa.
Che
quattre figlie maschie tu puózz'avé,
i
tutt' i quattre che bbona fertuna:
du’
carbeniére i du’ gran cavalliére. Svégliati,
bella mia, ch'adèsse è giorne: le
gallinèlle già per l’ara vanne. Pìgliati
l'accétta e va' pe légna,
a
fà cappotte[15]
con la tua compagna. Chi
taglia glie cappotte i chi glie ségna. Cappotte
da capocce de campagna.
Il canto una volta venne utilizzato per fare la serenata a due
sorelle, giovani e belle. Il cantore così si espresse:
"Che
bèlle spasse c'è da queste
luoghe!
C'è ‘na pianta de melegranate,
ce son due sorèlle ben
avernite[16],
me parno[17]
due colombe
accompagnate.
E
una cià il pètte tutto
fiorito[18],
e ‘n'altra il sole ‘nfrónte
‘ncatenato[19].
Io voglio buttà ‘na calamita,
una pe sposa e ‘n'altra pe cognata.
Io di bonasera ne lasce quattre,
una pe pizz’a quesso bianco lètte.
‘Mannisce ‘ne pèzze de pane i de presutte
i ‘ne pezzétte de ciammèlla tosta."[20]
A questo punto l’organettista, che era quasi sempre il compare Pèppe
‘lla Vólepa, volendo completare l’opera, smetteva di suonare e
raccontava:
“Apuó, no, loche vecine ce
stéva la pegnatèlla che ‘glie confiétte, i chélla (la ragazza)
ce ‘nfelè la mane pe chiappàglie; ma apuó nne la petéva recaccià i
allora disse:
- I mó cómme facéme? Tagliame la mane o rempéme la pegnatèlla?
-
Rempéme la pegnatèlla! – respenné une. I
acquescì rempiérne
la pegnatèlla. Eh,
eh eh!”
In altra circostanza il
racconto mutava:
“Apuó,
no, loche vecine ce stéva la sbucia ‘lla porta pe fa ‘ntrà la jatta[21]
i chélla disse:
- A ‘infila la mane iécche déntre!
Chiglie ‘nfelè la mane; ma ‘mméce de chiappà chélle che tenéva
chiappà, chiappà la jatta. Chélla, quanne se sentì strégne, ce screccà
ne mùcceche. Chiglie se féce male i se ne ì alla casa chiagnènne.”
L’immagine della mano che s’infila in una cavità ricorreva
quasi sempre a conclusione di canti, racconti e cose simili. Non so se
avesse un significato recondito. Mi piacerebbe saperlo, un giorno.
Canto di Natale
Il canto non mi pare un gran che. Tuttavia nel passato, quando tutti andavano in chiesa e la novena si faceva nelle ore antelucane (poiché dopo bisognava andare a lavorare), esso contribuiva a creare la giusta atmosfera natalizia: levandosi deciso e solenne in un formidabile coro all’unisono, dalla chiesa si diffondeva per le case e le vie del paese coinvolgendo l’intera comunità nell’attesa dell’Evento.
Sai
che vogl’io, dolce Bambino? Sposo
divino, ti voglio amar. Ti
voglio amar, sposo divino. Ti
voglio amar.
Voglio star sempre a te vicino,
caro Bambino, non mi scacciar.
Non mi scacciar, caro Bambino,
non mi scacciar. E
poi tu dimmi, vago mio fiore, sposo
d’amore, che vuoi da me? Che
vuoi da me, sposo d’amore? Che
vuoi da me?
Più non so darti, eccoti il cuore:
per man d’amore lo dono a te.
Lo dono a te per man d’amore,
lo dono a te. Gesù
mio caro, deh, non lasciarmi finché
a salvarmi non giungerò, finché
a salvarmi non giungerò, non
giungerò. La Palma 1°
Il canto veniva eseguito la domenica delle Palme andando di casa in
casa e portando come vessillo un bel ramo di olivo benedetto arricchito
con santini, nastri colorati e corone del rosario. L’esecuzione del
canto veniva premiata con uova o soldi.
La vocale e va pronunciata
distintamente.
Quando
Gesù se ne
volé partìe colla
sua madre-e-e, comincen
a parlare-e. Dicendo:
- Care figlie, a dó’ vó’ ìe? -
'n Gerusalèmme-e-e, dove
la pasqua faie-e.
-
'n Gerusalèmme non ci deve
ìe,
ca
glie Giudè-è-è te
vonno fraggellare-e. -
Chi mi vo’ fraggellà che mi fraggèlla, paciénza
ci aglie-e-e, paciénza
madre mia-a. ‘Mmiés'a
‘na morte la sapèva, cèrte, quanno
ci iéva-a-a a
fà razione all'orte-e. A
fà razione all’orte
ca ce iva col
mondo sie-e-e, noi
ce n'andiame
via-a. Noi
ce n'andiame
e n'andiame via
col
suo bel nome-e-e di
Gesù e Maria-a. E
gli angele ci canta a questa
casa, la
benedice-e-e, la
benedice Dio e lo Spirito Santo.[22] La Palma 2°
Questa versione, leggermente diversa, si cantava a Forcella.
Anche qui la vocale e va pronunciata
chiaramente.
La
morte di Gesù,
Maria s'affanna, Criste
che fuile-e, legato
a ‘na colonna-a.
Ci fu legato co gentille donne.
Giuda co gli atri
tradì gli angeli sante-e. Le
chiagne che faceva la Madonna: -
Curre, Giovanne-e.
Curre, Giovanne!
Ah, quanta pena porta!
Dal mio Salèmme-e
salvà glie faciarréme-e. Glie
faciarréme cómm'a fà glie ‘nganna, loche
ce stanne-e San
Piétr'e San Giovanne-e.
Ecco la palma a chi vo’ fà la pace,
ché noi n'andiame-e
e
voi restate in pace-e. Sia
lodato Gesù e Marie-e. La Passione
E' in lingua italiana. Il tempo è di 5
movimenti per battuta.
Quando
Gesù, sta in croce moribondo, Maria
ci sta sotto, ha un gran pianto. Mentre
sospira, al suo figliol giocondo Maria
mezza morta va parlando:
-
Gioia di mamma, figlio mio, che male hai fatto? Sei
stato sempre da tutti benedetto. Tu
mi portasti un mare di riscatto sopra
una croce lo vidde trafitto. Dopo
avuto una gran fune in canna[23],
in
croce lo vide morto la Madonna. O
cari miei, Giuda tradito siéte, non
tanta canità[24],
per caritate. Non
tanti strazi al figlio mio farete, non
tante spade al cuore gli donate.
Corri
Giovanni, fratello mio caro, consola
quella madre che sospira. Così
dicendo, con un sospiro amaro inclina
la testa e volge l'occhio al Padre. More
Gesù, in punto a ventun ora si
scura l'aria e si conturba il mare. Ancora
le pietre sentivano il dolore: la
morte di Gesù, che pianto amaro! Cala
Gesù al tronco della croce ‘nzino[25]
a Maria gliel'hanno dato. La
Matalena con quella treccia d'oro andava
piangendo tutt'afflitta e scura.
Chi
lo fosse visto? Il caro mio tesoro morto, se
lo vuoi, sta in sepoltura. Non
più, ti prego, vuol essere aiutato come
Gesù Cristo l'ha saputo. Non
più, ti prego. O verginelle pie, chiamami
in cielo, non mi fai dannare. Gesù
e Maria! Gesù
e Mara!
(recitato) Buona
Pasqua.[26] INNO
ALLA MADONNA DELLA MISERICORDIA
L’autore di questo inno è Manfredo Siciliani (1883-1962), il
maestro compositore di Balsorano (AQ) che ha diretto la banda di
Pescosolido nel Secondo Dopoguerra. L’inno viene qui riportato per
gentile concessione di Federico Siciliani, nipote del Maestro, e grazie
alla cortesia del parroco del paese, don Lino Ciccolini, che mi ha passato
la versione originale (manoscritta).
Madre di Misericordia, eccoci ai tui piedi. Deh, mira come vedi, non ci negar pietà. Pietosa volgi sguardi sopra questa cara terra, il demonio rio atterra ed amaci sempre più.
Portaci tutti in cielo; a noi date concordia. Madre di Misericordia, prega per noi, prega per noi, per noi Gesù ( 2v. )
Il quadro della Madonna della Misericordia ( fedele riproduzione del pittore Francesco Marchione).
[1] Al di là del fiume (Liri), nella zona di Valfrancesca - Compre. [2] Spighe di mais. [3] Nata nel 1900, sposò il
pastore Gnaziucce Tersigni,
che in estate se ne andava con le pecore in montagna, alla casèlla
che teneva aglie Cardite (uno spiazzo alle falde delle Cacchiete, tra glie
Favuótte e Puzze
Crevane). Peppinèlla da giovane era una donna bellisssima;
vestiva alla contadina, ma sempre in modo elegante: fazzolettone
ripiegato sul capo e fermato con una spilla, camicetta ricamata, busto
stretto alla vita, veste larga con grmbiule ricamato… Ma in lei
risaltavano soprattutto due bei riccioli biondi che le scendevano ai
lati del viso. Se glie facéva
ogne mmatina che du’ fiérre scallate aglie fuóche,
prima de ì a pertà la recotta alle segnòre de Sóra. [4] Ascoltati a Pescosolido nel 1998 durante una festa paesana organizzata dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, a cui hanno partecipato i campolesi Pasqua Rosa Preziosi e Vincenzo Carrafelli (Tabbacchine), che cantavano, e Pasquale Cirelli (Cianchitte), che li accompagnava con l’organetto. [5] “Mi voglio mettere in piedi vicino all’acquasantiera”. [6] Livorno. E’ evidente l’origine toscana dello stornello, che sicuramente è arrivato nelle nostre zone tramite i braccianti agricoli, che fino ad una cinquantina d’anni addietro si recavano a lavorare nella Campagna Romana per 7-8 mesi all’anno, come si rileva dagli antichi Registri Parrocchiali di Pescosolido nonché da altre fonti (Bernardino Tofani, Aprilia e il suo territorio, Aprilia 1986; Berardino Ferri, I Monelli, L’Aquila 1995). [7] Non mi ti fa sposare. [8] Riferitomi da Temistocle Siciliani (Mestecucce), bravissimo musicante di Balsorano. [9] Mucchio di spighe di mais, che bisognava liberare dai cartocci. Questi venivano conservati nel fienile per sfamare le bestie durante l’inverno o venivano usati per imbottire glie saccóne (pagliericcio); mentre “glie mazzuócche” (tutoli con chicchi di mais) venivano messi nei sacchi o nei canestri e poi trasportati nel granaio o, più spesso, sotto il letto matrimoniale che, dovendo servire da ripostiglio, era altissimo (tanto che per salirci, bisognava usare una sedia). [10] Dove si trovavano anche i futuri suoceri, i cognati, i nipoti ecc. Nel passato gli sposi novelli preferivano inserirsi in una famiglia già formata (normalmente quella dello sposo) per risparmiarsi, almeno in parte, le enormi difficoltà che la vita a due riservava, a cominciare dalla casa di abitazione che era quasi sempre introvabile. Così facendo, però, gli sposi dovevano rinunciare ai momenti d’intimità, i quali, non potendo avvenire in casa a motivo dei troppi occhi che guardavano e dei troppi orecchi che ascoltavano, avvenivano nei campi, nei boschi e sui monti, durante le pause del lavoro. [11] Era di vimini d’olmo o di salice scortecciati. [12] Era più grande del normale canestro ed era fatto di jùncete (giunchi) intrecciati artisticamente. Era un canestro di lusso, quindi. [13] L’organetto è il padre della della fisarmonica e, come in questa, il suo funzionamento si basa sul movimento di apertura e chiusura del mantice, che produce aria destinata a mettere in vibrazione le voci. Nella parte sinistra dello strumento si trovano i bassi per l’accompagnamento, sistemati a coppie verticali. In ogni coppia un bottone produce la nota basilare, l’altro produce l’accordo relativo. Il sistema tonale dell’organetto è fondato sul fenomeno naturale delle quinte: FA - DO – SOL – RE – LA ecc. Aprendo il mantice, tutti i suoni della melodia e dell’accompagnamento (tastiera e bassi) rientrano nell’ambito della Dominante; chiudendo il mantice, gli stessi rientrano nell’ambito della Tonica. Es.: DO (aprendo) – FA (chiudendo); SOL (aprendo) – DO (chiudento); RE (aprendo) – SOL (chiudendo) ecc. La Tonica (chiudendo) stabilisce la tonalità dell’organetto, che può essere in DO, in RE o in MI se ha due soli bottoni (bassi) nella parte sinistra. Vi sono però organetti che hanno 4 o anche 8 bassi (bottoni). Se lo strumento ha solo una coppia di bassi, può suonare solo frasi musicali basate su questi due accordi (tonica e quinta dominante). Se invece ha più coppie di bassi, può suonare su più tonalità. L’organetto si presta benissimo nell’eseguire frasi musicali molto brevi e lineari con frequente cambio d’accordi, che gli consentono di “respirare”: buoni sono i valzer, le polche e le mazurche di 8 o 16 battute. Ma migliori sono lo stornello e la ballarella che, eseguiti su due soli accordi (tonica e dominante) alternati battuta per battuta, consentono all’organetto di esprimere tutta la sua squillante ed allegra sonorità. Nel passato c’era anche qualche organetto dotato di “pietosa” (tonalità minore, che però quasi mai veniva usata). Oggi l’organetto pare che stia vivendo una seconda giovinezza: sono in molti a studiarlo ed a suonarlo. Ma probabilmente si tratta di entusiasmo passeggero, stante la disponibilità di strumenti moderni dalle prestazioni pressoché infinite (si pensi, ad es., alla fisarmonica elettronica, alle tastiere computerizzate, ai sintetizzatori). La presente nota è frutto della consulenza di cui l’amico Gianni Venditti, insigne direttore del coro della Cattedrale di Sora, mi ha fatto omaggio. [14] Prepàrati i panni. [15] Pettegolare. [16] Fornite fisicamente. [17] Paiono. [18] Rigoglioso, abbondante. [19] Due occhi splendenti come il sole. [20] Nel passato il non-sens ricorreva spesso nei canti, nei racconti, nelle filastrocche. Serviva per concludere o risolvere situazioni che altrimenti sarebbero rimaste in sospeso. Nel caso di questa serenata probabilmente esso viene usato per chiedere scusa alle due ragazze o forse per non creare in esse troppe illusioni, se mai se ne fossero fatte. I versi di questa serenata mi sono stati riferiti da Memmetta Conflitti-Marchione. [21] Si nota ancora in qualche casa abbandonata: era una buca quadrata o rettangolare situata nella parte bassa della porta (ottenuta tagliando lo spigolo destro o sinistro) e serviva per far entrare e uscire il gatto, ma anche le galline che a volte i contadini tenevano in cucina. [22] Il canto mi è stato riferito da Angela Lombardi-Marchione e da sua figlia Giacomina. [23] Alla gola. [24] Cattiveria da cani, accanimento. [25] In seno, sulle braccia. [26] Anche questo canto mi è stato riferito da Angela Lombardi-Marchione e da sua figlia Giacomina.
|